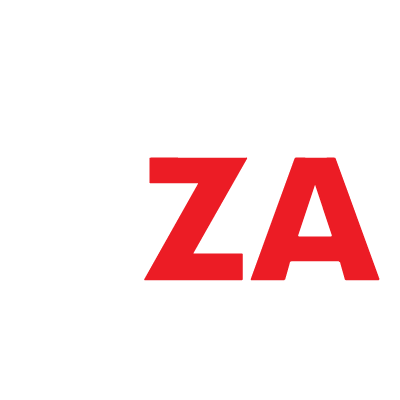Note di Regia di “Se Fate i Bravi” (Stefano Collizzolli)
Io c’ero, a Genova.
Non era un periodo di grande attivismo della mia vita. Gli entusiasmi adolescenziali, a metà fra il comunismo e Rimbaud, quelli dell’occupazione della scuola in cui si parla tantissimo di politica ma al contempo si prova a vedere se alla notte si riesce a scopare, erano un poco sospesi. Più avanti – e dopo Genova, in gran parte grazie a Genova, ma anche ai Balcani, all’ambientalismo, all’incontro con le migrazioni nella mia città- avrei trovato delle dimensioni di militanza e di tentativo di intervento nel reale. A primavera del 2001 ero uno studente universitario, in Erasmus in Belgio, e da lì in giro per l’Europa, molto più concentrato sulla mia vita che su qualsiasi altra cosa.
Avevo deciso da solo di andare a Genova; non ne parlavo con le persone che incontravo al bar o per la strada. Leggevo di notte i forum di Indymedia, scoprendo pezzo a pezzo una chiamata che mi pareva inderogabile. Argomenti, ragionamenti, pratiche che a partire da Seattle ed attraverso Porto Alegre parlavano esattamente di ciò che io ero, delle rabbie e dei desideri che mi muovevano, di una necessaria presa di parola per dire delle cose talmente ragionevoli che non potevano non essere ascoltate.
D’altra parte, loro “erano otto, e noi sei miliardi”, come si diceva. Sei miliardi di gabbiani ipotetici, per dirla con Gaber.

Da Genova mi sono rimaste le idee, i ragionamenti, le possibilità che poi hanno strutturato la mia vita adulta. Ma da Genova mi è rimasta anche un’altra cosa, forse più profonda, sicuramente più contraddittoria.
Fino a quel momento, per quanto fossi stato un adolescente vivace rompiballe e cagadubbi, pensavo allo Stato come quella cosa che mi dava in nome di tutti scuola ed ospedali; che poteva essere pro tempore in mano alle persone sbagliate, ma in fin dei conti era l’espressione della cura di sé della mia comunità.
Ci si poteva anche litigare, insomma; ma facendo poi la pace alla sera, come il Papa consiglia per i matrimoni.
Tra il 19 ed il 21 luglio 2001, ho realizzato che il mio Stato voleva uccidermi.
Che mi inseguiva per strada con lo scopo di farmi fuori: me, i miei amici, le migliaia di persone che erano con me in quei giorni non per distruggere tutto, ma per provare a dire che il debito andava cancellato, che era il caso di occuparsi del pianeta prima per il pianeta decidesse di occuparsi di noi, che la finanza ci stava mangiando la vita.
Che gli uomini e le donne che erano lì con le mani dipinte di bianco, ingenui ed irenici, o con delle tute sempre bianche, un pò meno ingenui, un pò meno irenici, ma ugualmente indifesi, eravamo tutti carne da macello, e ci restava solo da scappare come conigli, da disperderci l’un l’altro, da provare ad evitare una scarica di bastonate o peggio che pareva – che era – tanto inevitabile quanto totalmente assurda, inspiegabile.
Che alla dichiarazione molto limpida dei cattivi che in quel momento gestivano lo Stato, ovvero “vogliamo ammazzarvi tutti, e ricordate per sempre che se non vi ammazziamo oggi potremmo sempre ammazzarvi domani”, aveva risposto la posizione dei buoni, dell’alternativa ragionevole, quelli che non avevo mai votato ma che tutto sommato consideravo quasi dalla parte mia: “Ammazzateli pure. Noi, a Genova, ad interporci il giorno di sabato, dopo i fatti di venerdì, non ci verremo”.

Tra il 19 ed il 21 luglio 2001, ho realizzato che il mio Stato voleva uccidermi.
E, dal 21 luglio 2001 ad oggi, il mio Stato non ha cambiato idea.
Non c’è stata una commissione d’inchiesta parlamentare.
Non c’è stata un’assunzione di responsabilità. Per la morte di Carlo Giuliani non c’è stato nemmeno un processo; un GIP ha “escluso una responsabilità a qualunque titolo nella morte” a carico dell’unico imputato. In nessun momento in questi venti anni abbiamo ricevuto un segnale che quello, per lo Stato, è stato un errore, un momento eccezionale. Il segnale è quello opposto: fatti come Genova fanno parte dell’ordinarietà delle cose. Non sono una frattura, una smagliatura nella trama del presente. Di questa sostanza è costituita la maglia, tale è l’ordine delle cose, e tale è l’ordinarietà del potere.
Eppure io in questi vent’anni non ho fatto la rivoluzione. Non ho disubbidito per scelta a qualche legge fondamentale. Non sono neppure andato nei boschi per vivere con saggezza e per non scoprire, in punto di morte, che non ero vissuto. Sono un onesto cittadino, abito in una casa che possiedo con registrazione notarile, pago le tasse, mi appassiono dei modi e delle direzioni in cui si può politicamente gestire la forza del collettivo, come se questa forza non fosse necessariamente anche violenza.
Quando mi capita di dialogare con un ente pubblico, lo tratto con rispetto.
Dentro questa contraddizione è tempo di entrare.
Non faccio questo film perché sono pentito di ciò che sono ora, perchè devo regolare qualche conto con il me giovane che dormiva per terra in Piazzale Kennedy e discuteva fino a notte di un altro mondo che era possibile. Discuto ancora fino a notte. Contro ogni evidenza, continuo a credere che un altro mondo sia possibile; e non astrattamente: nella pratica quotidiana.
Però dopo vent’anni, è venuto per me il momento di entrare in questa contraddizione, di usare il distacco del tempo per tornare ad essere presente al sogno ed alla violenza di quei giorni, che sono la violenza ed il sogno di mille altri giorni. Una parte della mia generazione ha ancora una ferita aperta, da vent’anni, una ferita che lo Stato non ha intenzione di chiudere.
Ogni volta che la guardiamo, sanguina ancora un pò.
E’ il momento di affrontarla noi, di tornare ad aprirla se necessario, di guardarci dentro.
Nessun altro lo farà al posto nostro.
[Stefano Collizzolli]